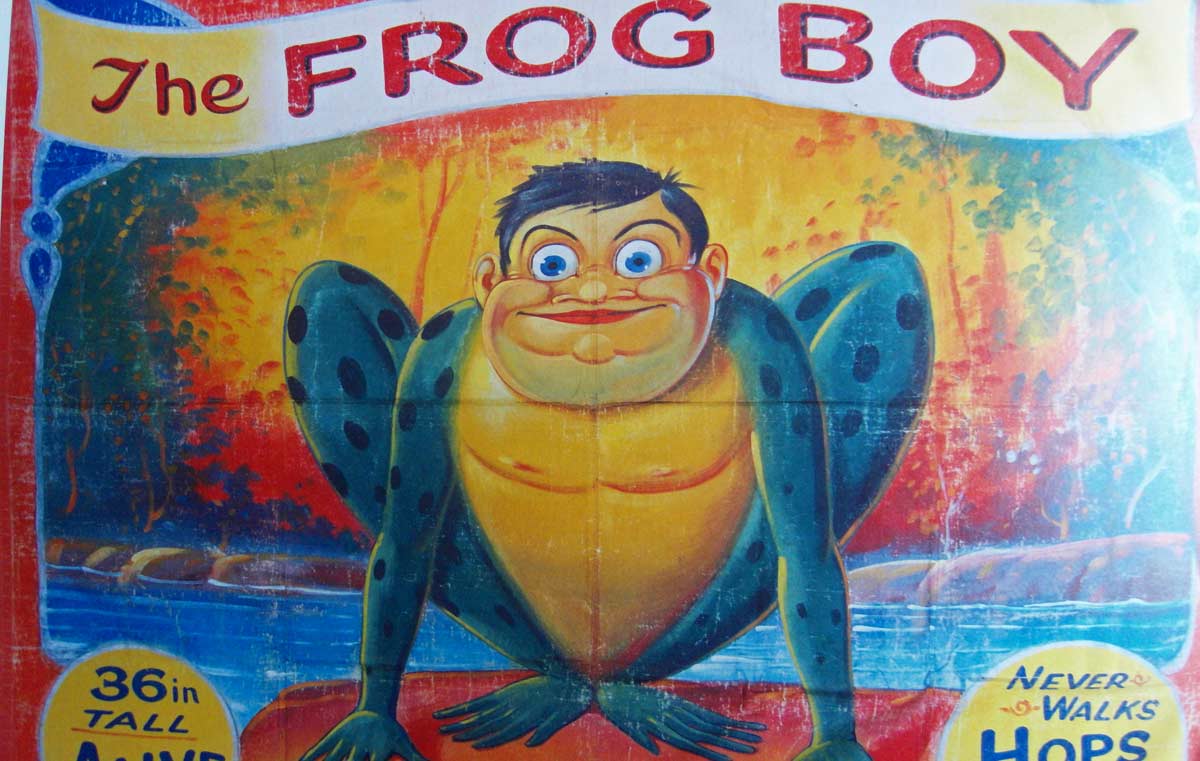Davvero “yes, we can”? O sarebbe più corretto dire che siamo prigionieri del caos? Provate a dire a una mosca intrappolata in una ragnatela: “Yes, you can…”. La ragnatela “aggrovigliata” è la tela più semplice e nello stesso tempo più disorganizzata da vedere.
É composta da una serie di fili attaccati a supporti lineari; niente a che vedere con l’immagine classica, geometrica, perfetta, a cui siamo abituati. Ed è proprio il disordine di questa struttura che diventa la trappola perfetta per la cattura degli insetti, proprio perché non viene riconosciuta come ragnatela!
Al ragno non resta che aspettare nella zona buia dell’agguato. Davvero “Yes, we can”, se non sappiamo più distinguere le trappole dalle possibilità? Un buon metodo per capire cosa siamo capaci di fare in questo mondo così complesso, è quello di restituire semplicità alle azioni e ai fatti umani.
Se guardiamo ai problemi essenziali del quotidiano, ci rendiamo conto che i nostri spazi di libertà e di autodeterminazione si riducono in misura proporzionale all’impossibilità di accedere ai servizi essenziali della sopravvivenza. Meno accesso alla verità deformata dai media, meno libertà; meno accesso alla giustizia, meno libertà; meno dignità nel lavoro, meno libertà. Per conoscere bene un paese è sufficiente visitare l’ospedale e il carcere. Quando il sistema di tutela della salute della gente e il sistema giudiziario non funzionano, si può facilmente immaginare che ci troviamo in un paese con una politica fortemente disegualitaria; un sistema profondamente ingiusto verso le categorie più deboli, verso i lavoratori, le famiglie, gli immigrati.
Cosa aveva in mente dunque l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama, quando con l’incoraggiante “Yes, we can…” aveva inaugurato questa nuova stagione dell’illusione collettiva per cui le intenzioni, soprattutto se propagandate efficacemente nei media e nei social, sono già una parte importante del successo? Il Premio Nobel per la pace, conferitogli il 9 ottobre 2009 “per il suo straordinario impegno per rafforzare la diplomazia internazionale e la collaborazione fra i popoli” fu il primo segno di come quel “Yes, we can…” era solo un efficace e retorico slogan da campagna elettorale. Niente più di questo. Niente a che vedere con le lotte sindacali degli anni ’70 condotte dall’United Farm Workers, o con le lotte per i diritti umani e contro la discriminazione razziale.
Cosa aveva fatto per meritare quel premio? Niente altro che alimentare la cultura dell’eroismo e dell’apparenza di cui il nostro tempo sembra avere tanto bisogno. D’altro canto le amministrazioni Clinton e Bush avevano prodotto un campo di sterminio di povertà e diseguaglianze e serviva una nuova illusione per riconquistare la fiducia della gente. Fra il 1990 e il 2008 l’aspettativa di vita degli uomini statunitensi bianchi senza titolo universitario si era abbassato di tre anni, mentre per le donne bianche con basso livello educativo era sceso di cinque. Un effetto simile lo aveva provocato solo l’AIDS in Africa meridionale. Ma come è potuto succedere? Non doveva essere l’era del progresso e del miglioramento delle condizioni di vita? Niente affatto; era l’inizio dell’era della nuova disuguaglianza, dell’illusione di una vita migliore, in cui, come ricordava lo scrittore Eduardo Galeano, “ci troveremo tutti a novant’anni confortati dal viagra e dalla chirurgia plastica ma incapaci di ricordare come servircene”.
Nel suo discorso di addio alla presidenza, Barack Obama aggiustò notevolmente il senso del suo slogan, suggerendo a tutti: “compratevi un paio di scarpe e camminate da soli”. La storia della responsabilità collettiva divenne un’enorme balla. Nel frattempo il “yes, we can” ha continuato a cavalcare l’onda di una cultura di massa in cui è comodo pensare che tutti possiamo avere successo: basta lasciarsi incorporare nel racconto determinato dalla società capitalistica. Il racconto di una società positiva dove per esistere devi apparire, devi essere visibile. Non importa cosa pensi e non hanno significato i tuoi dubbi. Basta dire sì, basta pensare che possiamo farcela e tutto cambia. Ma quando cambia?
Proprio qui nasce la fregatura: oggi non può cambiare, perché oggi sei sempre dentro una storia non tua, una storia fatta di tanti domani: la tecnocrazia, l’economia e il potere ti hanno educato a esistere in quanto individuo che funziona, produce, comanda e possibilmente dimostra di saper sopraffare l’altro. La narrativa del potere ha distrutto il presente a tutto vantaggio di un domani inesistente, o perlomeno, inesistente per come te lo immagini tu. E allora diventa sempre più urgente recuperare la capacità di una narrativa personale del mondo e della vita. Diventare autonomi, riconoscendo che la nostra storia è fatta di tante storie; osare il cambiamento, cercare la differenza e non ossessionarci nella ricerca di un’identità immutabile.
Perché noi siamo il risultato di quello che riusciamo a raccontare; un album di foto con storie diverse, con tanti “noi” come le immagini sconnesse di un diario anonimo. Possibilmente senza aspettare quel domani che il nobile Macbeth vedeva come “ingannevole parola”, quel domani ossessivo e illusorio che “ci porta, giorno dopo giorno, al Sepolcro” (Macbeth Att.5 scena V).
Dobbiamo saperci raccontare come figli dei giorni che passano e non ci appartengono.